Sulla piazza di Menà si può compiere un viaggio a ritroso nel tempo: la nuova chiesa degli anni Settanta, la vecchia chiesa ottocentesca, ormai in rovina, l’antico oratorio del Cinquecento dedicato a Sant’Anna. Lassù, dalla lanterna del campanile che svetta sulle tre chiese, vengono sette rintocchi di campane a risvegliare un silenzio sospeso tra il qui e ora e qualcosa di lontano e antico. Sono sceso fin quaggiù, nell’ultima propaggine della provincia veronese prima del rodigino, a cercare storie di briganti.
La chiamano anche Menà di Vallestrema. Una terra estrema, dunque. Non mi sorprende che su questi campi, tra i canneti delle paludi, lungo gli argini dei canali, al riparo dei pioppeti, si dessero alla macchia briganti i cui nomi sono stati custoditi dall’immaginario popolare, pronunciati e tramandati di racconto in racconto.Era l’inizio dell’Ottocento, il “secolo dei briganti”, e se nel Regno di Sicilia c’era Pasquale Bruno, che ispirò Alexandre Dumas, in Abruzzo Pronio, a Napoli, Sciarpa, Fra Diavolo e il Taccone, nello Stato Pontificio Gasparrone, in Romagna Stefano Pelloni, detto Il Passatore, in Lombardia Paci Paciana e nel veronese non si era ancora spenta la fama del brigante Falasco, vissuto due secoli prima, qui si muovevano Giaron dela Menà, Petiol da Spinimbecco, Balin e il leggendario Nineta, il più temuto e ricercato. Mi perdo in questa campagna. La tangenziale che corre parallela all’Adige mi sbarra la strada, invalicabile più del fiume. Guardo un casolare di mattoni rossi, semicoperto dalla scarpata del cavalcavia, e, a circondarlo, i regolari filari di pioppeti che ombreggiano di un insolito sole novembrino. Tutto, quaggiù, evoca il ricordo di un mondo contadino scomparso.Alla Cà Vecchia un capitello mi riporta l’eco della fede dei poveri che, con la fine della Repubblica di Venezia (a fine Settecento) insieme ai Francesi videro arrivare nuove tasse, requisizioni di beni per soddisfare le necessità dell’esercito e arruolamenti obbligatori di giovani mandati in giro per l’Europa a combattere le guerre di Napoleone. Quando, a Castagnaro, si assistette alla chiusura voluta dai Francesi delle congregazioni della Beata Vergine e di San Francesco d’Assisi e alla requisizione e svendita dei beni comunali, la gente si ribellò. Nel 1806 i briganti assaltarono il municipio e, devastatolo, bruciarono in piazza tutte le carte e i registri con cui chi comandava vessava i poveri, sempre più poveri.Ma ora cammino verso l’Adige. Alle porte di Castagnaro le sue acque defluivano in un canale chiamato Diversivo. Per controllarle, i Veneziani costruirono a fine Settecento il così detto Ponte della Rosta. Dall’argine su cui poggiano i suoi contrafforti, scendo allo specchio d’acqua del fiume che oggi, gonfio, pare un lago. Questa lama rifrangente il cielo divide la pianura veronese e mantovana da quella rodigina e padovana. Un confine invalicabile? Tutt’altro. Gli scambi, anche un tempo, erano frequenti e consuetudinari, grazie ai barconi che univano le due sponde. A Brazzetto, tra Begosso e Carpi, ne furono rubati sei che servirono a dei disertori per fuggire alle caserme austroungariche e così non essere mandati in guerra e piuttosto diventare briganti. Ieri, come oggi, i giovani disertano le guerre: possiamo davvero chiamarli traditori?Percorro il tracciato dell’antica Strada Bassa di Vigo che proseguiva fino a Badia Polesine. I briganti, che non dobbiamo immaginare certo come “ladri gentiluomini”, organizzati in bande assaltavano le diligenze e non disdegnavano depredare le case, come fecero nel 1809 a Villa Bartolomea. Corso Fraccaroli è un velario scenografico su cui sono dipinte, nel sole autunnale che le illumina come un proiettore teatrale, la chiesa di San Bartolomeo, la Biblioteca Comunale, il Teatro Sociale, le scuole elementari (torniamo a chiamarle così e aboliamo quel repellente Primarie!) e il municipio. È nel suo archivio che Francesco Occhi ha scovato le carte che dicono dell’assalto dei briganti nel 1809, quando requisirono quattro buoi, intimarono il sindaco di dar loro pane, formaggio e vino e rapirono perfino un gruppo di cittadini per portarli, prigionieri, a Legnago. È tra queste carte che venne rinvenuto il mandato d’arresto di 1822 di tale Francesco Neri, detto Nineta.«Te gh’en fe pì de Nineta», si dice ancora oggi a qualcuno che si prodighi a combinare guai. E chi lo sapeva che Nineta non era una ragazzina pestifera, come ho sempre immaginato, ma il nome di un famigerato brigante delle Basse?Nato a Isola Porcarizza (l’antico nome di Isola Rizza) Nineta appare nella descrizione del documento che ne chiede l’arresto come un giovane snello dai capelli lunghi e ricci, con fazzoletto rosso e tabarro bianco. Un brigante vestito di bianco: immagine leggendaria! E la leggenda vuole che Nineta, che usava assaltare le carovane da solo fingendosi a capo di una banda, non fosse mai stato arrestato, anche se sull’atto di nascita di suo figlio, il parroco scrisse che il padre si trovava in carcere nel padovano, dove morì, forse nel 1831.Percorro, in compagnia del suo ricordo, la strada che porta a Vigo dove, nel 1809, una guarnigione francese mise in fuga i briganti che avevano assaltato Villa Bartolomea. Petio da Spinimbecco venne ucciso, Giarol dela Menà venne trasportato con gli altri briganti a Legnago. La città mi appare dall’argine del fiume che l’ha generata e che storicamente la divide. Osservo, in Via Leopardi, gli ultimi lacerti delle antiche mura, sviliti in muro di cinta di un parcheggio. Immagino Porta Ferrara, dove ai piedi dello spalto vennero fucilati i briganti. E rimpiango la stella che Michele Sanmicheli progettò a proteggere la rocca, quando vennero ricostruite le antiche mura del X secolo.Delle quattro torri circolari erette nel Quattrocento rimane solo il Torrione. La sua statuaria imponenza fa immaginare come doveva apparire questa città fortificata che, tra fine Settecento e fine Ottocento, fu prima veneziana, poi francese, poi austriaca, infine italiana. Ognuno dei nuovi arrivati si proclamò, manco a dirlo, liberatore. La Storia è dunque piena di liberatori dai quali saremo, presto o tardi, liberati.Camminando sull’argine, nel sole che tramonta dietro al Monumento ai Caduti, canticchio la filastrocca tanto cara ai briganti: «Co Venezia comandava, / se disnava e se zenava. / Coi Francesi, bona zente, / se disnava solamente. / Co la casa de Lorena, / no’ se disna e no’ se zena. / Co la casa de Savoia / gh’è rivà na fame boia». D’altronde, come dice il proverbio: «Cambiar paron l’è come cambiar molinaro: te cambi ladro».



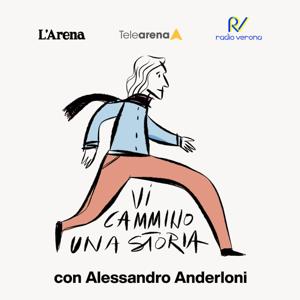

 View all episodes
View all episodes


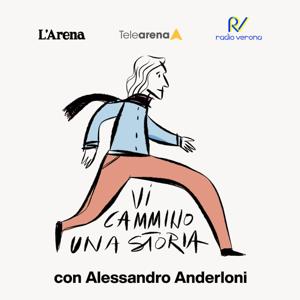 By Gruppo editoriale Athesis
By Gruppo editoriale Athesis