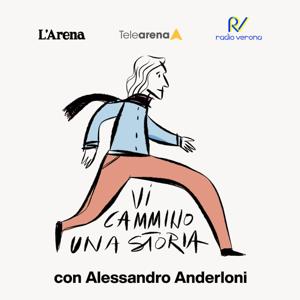Partiva da Fane alle 11 di mattina, la Mariolina. Aveva dieci anni, e nei giorni di vacanza toccava a lei portare da mangiare a suo papà, el Siena, che lavorava nelle Preare di Prun. A mezzogiorno doveva essere di là della valle. Parto anch’io, all’alba, e dalla chiesa di Fane mi infilo giù, ad attraversare le vie di un paese che non ha una piazza, le cui case dai tetti di pietra si distendono sul fianco del vaio. Si chiamano così le incisioni profonde che tagliano la Lessinia verticalmente, più strette di una valle. Questo, per gli abitanti di Fane è il Vaio de Prun, per quelli di Prun il Vaio de Fane, come se nessuno lo volesse. Dall’altra parte, nel primo sole, mi sento guardato dagli occhi neri delle preare. Le hanno sempre chiamate così: Preare di Prun. Forse perché in latino praebere si può tradurre anche cavare, o perché la pietra, quassù, è la pria. A chiamarle Cave di Prun si iniziò in tempi recenti, per il nostro vezzo di italianizzare i toponimi dialettali, come se volessimo liberarci di un passato che ci interessa sempre meno.
Il sentiero che scende tra i faggi e i carpini è un ristoro dell’anima. Sento lo scroscio del torrente. L’acqua è chiara, fresca e dolce, parafraso, con le parole del poeta. E penso alla Mariolina che, con le altre bambine di Fane, con le sgalmare di legno scendeva e risaliva il vaio, per nulla spaventata dalla fatica, ché i bambini erano abituati a camminare. E camminando parlavano, giocavano, cantavano, e crescevano, più sani e robusti, forse anche più felici. Nella sporta de paia la Mariolina portava una ramineta con dentro il minestrone o la pastasciutta, un tegamino con patate o broccoli, e poi salado o bóndola o formaio, con du paneti e, in una bottiglia, un po’ di graspia: il vino dei poveri, in questa valle che ora produce e vende vino pregiato ai ricchi di tutto il mondo.Ti viene voglia di correre, sul sentiero che saltella di qua e di là del fosso. Correva la Mariolina, e le capitava così di spandere un po’ di minestra tanto che, arrivata alla fontana della Vallecchia, la allungava con l’acqua, sperando che el Siena non se ne accorgesse. La strada che sale da contrada Castello è delimitata da un lato dalle lastre verticali conficcate a terra, dall’altro dai muri a secco, con pietre incastrate a lisca di pesce. La prima preara che incontro è quella dei Russi, l’altra, custodita con amore dall’Associazione La Malga, del Spadon. Illuminati di taglio da una lama di sole, sui pilastri che sostengono le volte di pietra sono perfettamente leggibili i 73 strati di lastre che la Natura ha fornito all’Uomo già tagliati, pronti per essere estratti e messi in opera. Si tratta di Scaglia Rossa Veneta o lastame del Cretaceo. La chiamano, da secoli, Pietra di Prun, anche se commercialmente funziona di più Pietra della Lessinia.Fa girare la testa pensare che questa pietra si è formata cento milioni di anni fa, quando queste terre erano coperte dalle acque dell’Oceano Tetide, con un impasto di detriti, conchiglie, frammenti di molluschi e altri organismi marini che si depositarono e compattarono sul fondale. Come una spugna, da questi strati l’acqua in milioni di anni fuoriuscì, lasciando a dividerli sottili veli di argilla. I cavatori a ogni strato avevano dato dei nomi di fantasia, ma che rendono bene l’idea: la pietra di qualità era el meion, quella meno pregiata la lóa; quella che si lasciava cavare facilmente era zentil, quella difficile da cavare rabiosa; a seconda della pigmentazione si distingueva el biancon, el rosson e la lóa rossa, a seconda dell’utilizzo la piera da querti, la piera da seciar e la lastina. Gli amici dell’Associazione La Malga hanno recuperato un antico carro con cui buoi e cavalli trascinavano fuori dalle cave le pesantissime lastre di un metro per quattro, e, dentro alla cassetta di legno, gli attrezzi dei cavatori e degli scalpellini: ponte, massete, ponceti e bociarde. C’è anche una lampada a carburo. Quando entro nella cava, la luce calda della tremolante fiamma e l’inconfondibile odore dell’acetilene mi riportano a un tempo irrimediabilmente perduto.Iniziato nell’Età del Ferro, continuato con i Romani, poi nel Medioevo, nel Rinascimento e nel Settecento, l’utilizzo della Pietra di Prun fiorì negli anni Venti, quando in queste cave lavoravano duecento persone, tra cui el Siena, che frequentava anche la scuola per scalpellini di Prun. Alcune cave chiusero negli anni Trenta. Dopo la guerra ci fu una ripresa: serviva pietra per ricostruire Verona. Con l’inizio dell’escavazione a cielo aperto a Sant’Anna d’Alfaedo, negli anni Cinquanta, a poco a poco vennero dismesse, fino alla chiusura definitiva nel 1957.Mi addentro, tra le colonne di una cattedrale di pietra. Brilla alla luce del carburo, in una vascone, l’acqua con cui gli esperti forgiatori tempravano le punte. Sui bancali, così vengono chiamate le pareti, si leggono gli strati delle lastre e le mani dei cavatori che le hanno cavate, scolpendo da destra a sinistra e, i mancini, da sinistra a destra. Sotto una nicchia con un crocifisso e la data del 1955, tutto è rimasto come nell’ultimo giorno di lavoro: le lastre pronte, sui rulli di legno, con il foro per la leva che li faceva rotolare. Ci sono ancora i ponceti sotto una lastra già tagliata. Mi pare di vedere i cavatori, impolverati, seduti sulla loro cassetta di legno, a dare martellate. Quanta fatica! Uscendo, abbacinato dal sole, penso alla fame che doveva avere el Siena, quando a mezzogiorno rimproverava la Mariolina allorché arrivava qualche minuto in ritardo. Quella volta che lei portò del cibo che a lui non piaceva, el Siena buttò tutto nel bosco, per poi guardare la figlia, pentirsene e andare a raccoglierlo, mangiando quello che restava.Scendo da Prun verso Torbe, osservando i muretti, le case, le torri colombaie, le fontane e i lavatoi di pietra. Questa valle è stata modellata dalle mani di uomini rudi che alle parole preferivano i gesti, all’indolenza la tenacia. Ci hanno lasciato edifici che trasudano bellezza. E noi, cosa lasceremo? In contrada Mospìgolo in un cantiere di restauro si riutilizzano le antiche pietre. Ecco, forse abbiamo finalmente preso coscienza del valore di questa architettura vernacolare.Concludo il mio camminare là dove il Vaio di Prun (o di Fane) diventa Valpolicella, alle porte di Negrar. Grandi tensostrutture proteggono gli scavi archeologici della Villa Romana. Il portico, l’area termale, le vasche per la vinificazione e le lastre che contornano i preziosi mosaici sono state cavate proprio lassù, nelle preare: monumenti alla memoria.